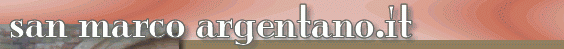 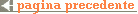 |
 Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti. Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti.
una lievitazione linguistica ... 
Non c'è una sola regione italiana in cui il frutto che si vede nella cesta venga chiamato ciliegia,
mentre, se cerchiamo l'origine del suo nome, tutti i dizionari ci diranno che la ciliegia deriva dal latino
cerasus, a sua volta originato dalla voce greca kerasos.
Non c'è che dire. Tutte le regioni italiane, la nostra compresa ovviamente, hanno mantenuto quasi inalterato il nome originario dell'albero ceraso e del suo frutto, la cerasa nei rispettivi dialetti e, invece, l'italiano presenta due voci molto diverse, quali sono appunto ciliegio e ciliegia come "legittimi discendenti" degli etimi greco-romani. È "legittimo", a questo punto, chiedersi da dove saltino fuori questi due strani vocaboli con i loro inspiegabili suffissi gio e gia, che non ci azzeccano un fico secco con la presunta nobile discendenza. Essi rientrano tra le voci bastarde che nessuna regione ha legittimamente rivendicato come proprie. Il fatto è che ciliegia deriva da celegia o selegia, due voci che troviamo nel periodo in cui il latino classico si era "imbastardito". Bisogna ammettere che esse ebbero una fortuna inaspettata, tenendo conto del loro significato, per mantenersi in buona salute fino a trasferirsi pressocché inalterate nella nostra attuale voce ciliegia. Com'era questa nostra antenata di nome celegia/selegia? Rossa, polposa, amarognola, grossa, piccola? Nulla di tutto questo. Era liquida. Sissignori, avete letto bene, perché non si trattava di un frutto, ma del prodotto della lavorazione della cerasa, trasformata in una bevanda fermentata. Un po', giusto per fare un esempio, come l'uva e il vino, dove quest'ultimo è il prodotto che si ottiene dall'uva, così la celegia/selegia era il risultato della fermentazione della cerasa. Il dizionario che ci riporta questa antica voce è il Glossarium dei termini antichi di Du-Cange, che paragona la bevanda alla birra, la cerevesia, spiegando come quest'ultima si ottenga dalla fermentazione dell'orzo. Poiché la celegia/selegia si otteneva attraverso la trasformazione dello zucchero contenuto nella cerasa si ha l'impressione che tra i due prodotti vi fosse una qualche affinità, quanto meno nella radice di cervesia e cerasa, entrambe riconducibili alla dea Ceres. Non saprei dire se questo accostamento abbia un fondamento o sia improponibile, ma sta di fatto che a qualcuno venne in mente di utilizzare la cerasa nella fermentazione della birra per renderne il gusto più fruttato. In questo intreccio di lieviti e zuccheri preposti a rendere le bibite alcoliche e inebrianti, la celegia/selegia si è mantenuta più sobria del suo originario frutto, guadagnandosi, anche se in maniera discutibile, il diritto a rappresentarne le caratteristiche sulla nostra tavola e, quel che più conta, nella nostra lingua ufficiale. A chi si deve questa avanzata rispetto a tutti gli altri idiotismi regionali, legittimi portatori del nome originale? A me sembra che la risposta sia ovvia: a chi fece lievitare la cerasa per farla fruttare a proprio vantaggio. A quanto ho potuto leggere, tranne che per il liquore, l'iniziativa di produzione della celegia/selegia non ebbe molto successo, ma il tentativo fu premiato, rappresentando l'unico caso di riconversione del succo in frutta. Sotto il profilo linguistico, ovviamente. San Marco Argentano, 5 ottobre 2025 Paolo Chiaselotti |
| |