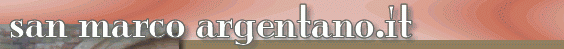 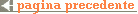 |
 Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti. Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti.
pasta o verdure? ...  Siamo sicuri che il piatto 'lagane e ciceri' sia composto da pasta e ceci? E se fosse, invece, di verdure e ceci?
Siamo sicuri che il piatto 'lagane e ciceri' sia composto da pasta e ceci? E se fosse, invece, di verdure e ceci?
"Mo' è jisciutu u spiartu ca ni cunta n'atra minchiata!" immagino che dica il lettore
dopo aver appena letto il titolo. Mi chiedo se sia io a dire le minchiate o milioni di persone che prima di me hanno stabilito ciò che mi accingo a confutare. Poiché la probabilità che sia io a sparare minchiate, piuttosto che milioni di persone, è altissima, cercherò di circoscrivere il loro numero strettamente a coloro che furono all'origine di una tale minchiata secolare. La loro interpretazione, universalmente accettata, attraverso pubblicazioni di ogni genere, ha finito per diventare patrimonio culturale della nostra cucina. Nel caso della pasta, quella italiana, di cui siamo indiscussi intenditori e fruitori, una volta che le fu accostata la lagana e le varianti lessicali, chi mai avrebbe avuto il coraggio di dire: «Scusate, mi sono sbagliato », togliendo da sotto il mento un piatto di lagani e ciceri per sostituirlo con uno di verdura e ciceri? Solo un pazzo, un 'chi t'è muortu, avrebbe osato, non solo fare, ma pensare una cosa del genere! Centinaia di anni, decine di ricette, innumerevoli interpretazioni linguistico-gastronomiche hanno sancito che làgana, làgane, làghini, làina, làine, lacne, làccane, làcchene sono sempre e solo pasta. E làganaturu, laghinaturu, lainaturu è il mattarello per stenderla a dovere. Per risalire all'origine di questa parola ho chiesto all'intelligenza artificiale di dirmi quando, per la prima volta, fu usata la "lagana" con significato di pasta. Ecco la risposta: "La parola latina laganum, da cui deriva l'italiano "lagana", veniva usata fin dal I secolo a.C., come confermato da Orazio, per indicare uno strato piatto di farina cotta in acqua, considerato un antenato della lasagna. Non si sa quando esattamente fu usata per la prima volta in italiano moderno, ma l'uso del termine è documentato nell'antichità romana per descrivere questo tipo di pasta." Approfondendo la ricerca ho trovato che in taluni casi si fanno derivare le lasagne dalla lagana. L'autore latino che per primo utilizzò la parola "lagana" fu il poeta Orazio nelle Satire (1,6,115,2), riferendosi ad un piatto modesto a base di porro, cecio e lagano (porri et ciceris et lagani catinum). Quasi tutte le traduzioni riportano al plurale gli ingredienti del piatto e quel lagani, che tradotto alla lettera significa "di lagano", fu interpretato "di frittelle". In altri autori la voce è lasciata inalterata, ma interpretata come plurale di un ingrediente non meglio specificato. Il termine latino trae origine dal greco λάγανον e corrisponderebbe al latino tractum, a cui M.P.Catone attribuisce il significato di pasta sfogliata. Da qui molti interpreti del testo di Orazio hanno tratto il significato di un composto a base di farina, per alcuni rimasto intatto, una sorta di sottile sfoglia, per altri delle strisce ricavate da detta sfoglia. Orazio non specifica di cosa si tratti e tantomeno se fosse o meno tagliata. Tuttavia, tanto è bastato, per far nascere le lagane che oggi conosciamo. A contribuire all'interpretazione di un impasto a base di farina da unire a porri e ceci fu un altro autore latino, un tal Marco Gavio Apicio, gastronomo del I secolo a.C., nell'opera "De re coquinaria". Egli, in due ricette riguardanti la preparazione di due piatti, uno a base di latte e l'altro di uso quotidiano, si avvale ripetutamente del termine latino, sia nella forma singolare "laganum" che al plurale, "lagana". Dalla preparazione dei due piatti si evince chiaramente che si tratta di crespelle o omlette, disposte a strati con una elaborata farcitura. A guastare il tutto, però, fu un vescovo, tal Liutprando di Cremona, vissuto nel X secolo che nella sua opera polemica "Antapodosis", esattamente nel libro V, al capitolo 23, dice: "Dulces adsunt fabæ, Lachana porrique recentes. Il Du-Cange, nel suo Glossario del latino medievale definisce quel Lachana, "olera, greco Λάχανα, i.e. herbae, cioè verdura, ortaggi, in poche parole: erba. Viceversa alla voce tardo-latina lagana il Du-Cange ci indirizza su tutt'altra strada, nientemeno che a mare! Vale la pena spendere qualche parola in quest'acqua 'salata', che non riguarda la bollitura, bensì ciò che galleggia sulle acque dopo un naufragio. L'insieme delle cose perdute a mare era chiamato in tardo latino lagan o laganum, al plurale lagana e il loro ritrovamento e relativo possesso era una cosa talmente seria, per le implicazioni giuridiche e morali che ne derivavano e che coinvolgevano non singole persone, ma luoghi, porti o stati presso le cui coste avvenivano i naufragi. Mettendo da parte questa complicatissima faccenda, potremmo pure pensare ad un accostamento delle "lagana" (la voce latina è un plurale) ad un brodo di cottura entro il quale le nostre 'fettuccine' galleggiano! Se andiamo a cercare una risposta in un etimo greco, λαγάνιον, ου, τό era una elaborata focaccia con farina, miele e olio, mentre λαγαρίζομαι significava vivo con poco, ovvero di sola focaccia. È indubbio che stiamo parlando di un impasto di farina. Il fatto, però che tra tali voci greche e la lagana italiana non vi sia una voce intermedia del basso latino, o di altra lingua, interrompe l'uso di quella parola in epoche successive. Identica cosa accade per la voce latina "laganum, i" al plurale "lagana" che non troviamo in nessun documento in lingua tardo latina o volgare italiano, tranne nei significati sopra accennati di relitti marini! La radice greca λάχαν- (lachan-), con la χ (chi) al posto della γ (gamma), che rimanda a voci tutte legate all'erbaggio, è l'unica che prosegue la sua vita linguistica fino al nostro primo italiano volgare assumendo la forma lachana, col significato di verdura. In parole povere chi ha adottato per la prima volta la parola lagana, come oggi la conosciamo, per indicare la pasta, lo ha fatto andando a pescare la parola nel latino e nel greco. Ha fatto cioè un'operazione "culturale", la stessa che un ristoratore potrebbe fare presentando tra le salse e i condimenti un "garo", dicendo che si tratta della versione tradizionale garum degli antichi romani a base di interiora di pesce. Un intraprendente produttore di alimenti a base di pesce lo ha fatto, usando la voce originaria latina. Quando e da chi sia nata la parola italiana "lagana" non lo sappiamo, nè sappiamo se tale operazione di marketing abbia realmente rispettato i propositi di Orazio, quando nelle sue Satire si riferisce al suo semplice piatto. Per stabilire se lagane e lasagne sono realmente quel prodotto a cui Orazio fa cenno è opportuno interpretare i suoi versi per capire che cosa abbia voluto dire con quel catinum di porrus, di cicero, di laganum, cioè descritto nei suoi singoli componenti al singolare: un piatto di porro,cecio e lagano. Quel lagano, interpretato ora come frittella, ora come pasta, trova, guarda caso, in una parola espressa poco prima da Orazio, una sorta di strana assonanza. Nei versi precedenti Orazio, infatti, irride un senatore seguito da fanciulli che portano un lasanum, un cantaro, e un oenoforum, una fiasca di vino. Oltre all'enormità delle portate, ciò che colpisce è soprattutto quel lasanum (volgarmente un pitale o vaso da notte) che somiglia foneticamente alla lasagna, ovvero alla sfoglia di pasta che l'etimologia corrente vuole da esso derivata. Per sapere come la nostra lasagna sia uscita da un vaso da notte, Papias, che fu un grammatico dell'XI secolo, ci spiega che ai suoi tempi, la parola latina che nel frattempo si era evoluta nella forma lassanum, indicava il vaso in cui si svuotava il ventre. Ne spiega anche l'etimo: perché in esso si rilassava l'ano ("sic dictum quod in eo laxetur anus") (Du-Cange). Credo che non sfugga a nessuno il fatto che la nostra pasta, lasagne, fettuccine o un'improbabile frittatina, discendano da due voci che hanno tutt'altro significato o sono sconosciute, come nel caso del 'brodoso' laganum. Se Orazio sottolineava la frugalità del suo pasto, dobbiamo ritenere che alla sua zuppa a base di porro e cecio non potesse assolutamente aggiungere della pasta che, comunque cotta, necessitava di una preparazione. A lui bastava la sola aggiunta di verdure, quelle che noi troviamo scritte nella dizione lachana di Liutprando, vescovo e storico vissuto nel X secolo. Se andate in Grecia e chiedete un piatto di cavoli, il cameriere vi chiederà: «λάχανο?» Chi fu all'origine di una tale 'falsificazione'? Certamente chi aveva a cuore la cucina, tanto da proporre in termini latini una propria passione per la pasta. O un proprio interesse, in quanto produttore o rivenditore. A voi sembra eccessivo? Stranamente questa storia del vaso da cui fuoriescono gustose lasagne l'ho letta su un antico, o presunto tale, libro di cucina ... su cui fior di studiosi, più che il culo, ci hanno messo bocca. Insomma, ci hanno presentato, per restare in tema, focaccia per pane. In fondo, però, è meglio così, sia perchè ai ceci aggiungiamo altre proteine e sia perché non vogliamo competere con chicchessia per frugalità a tavola. Se vogliono, lo facciano i nostri senatori. San Marco Argentano, 13 settembre 2025 Paolo Chiaselotti |
| |