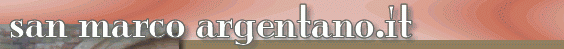 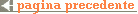 |
 Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti. Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti.
Una storia slava ... 
Il sottotitolo di questa pagina di sutt'a linngua rientra tra le mie ricerche di
testimonianze slave nel nostro territorio. Tranne alcuni toponimi e la voce magare,
finora non mi era mai capitato di imbattermi in un altro vocabolo da noi usato, la cui
etimologia è anch'essa slava.
Si tratta di una pianta acquatica che noi chiamiamo vuda, quella per capirci che nasce in ambienti acquitrinosi e si riconosce per una spiga di color marrone simile ad un wurstel infilato all'estremità di una cannuccia. Insomma, quello che si vede nella foto in alto. Il nome italiano è tifa, e appartiene alla famiglia delle tifacee. Nel mentre il nostro vocabolo vuda deriva dallo slavo, con significato di acqua, la voce italiana deriva dal greco e ci ricorda molto la malattia detta tifo. Ebbene dietro queste due parole c'è una storia che oramai anche le pietre del fiume conoscono, ed è quella del Guiscardo che lascia Scribla per venire a San Marco. Assieme a lui ci sono sessanta sclavi (oramai lo sanno anche i bambini) che a Scribla continuavano a deperire a causa della febbre malarica. A quel tempo in Calabria dominavano i bizantini e sarebbe stato ovvio e naturale che il loro vocabolo "τύφη", thyphe nella forma italianizzata tife o tifa fosse stato ereditato da noi calabresi. E, invece, ad imporsi nel corso della nostra storia e nella nostra cultura fu il corrispondente vocabolo slavo "Вода" (pron.:voda) che significa acqua. Vediamo di capire che cosa c'era dietro queste due voci. Per i greci essa era legata al luogo di origine "τϊφος", la palude, e di conseguenza alla malaria, tanto che da tiphos è derivata la parola tifo. Per gli slavi, o per meglio dire per gli sclavi (erano chiamati anche sclaveni), la parola che indicava quella pianta era collegata all'acqua, grazie alla quale la pianta si alimentava. Sarebbe stato giusto che ad usare la propria parola (e a subirne le conseguenze!) in Calabria fossero i bizantini, invece furono gli sclavi a provarne gli effetti. Ciò, nonostante, costoro continuarono a chiamare rispettosamente quei bastoncini e l'intera pianta con lo stesso nome con cui chiamavano l'acqua che quotidianamente bevevano e che consideravano sacra fin dalle antiche tradizioni pagane. O per ingenuità o perchè costretti, sta di fatto che il loro sacrificio fu premiato a tal punto che ancora oggi noi sammarchesi abbiamo conservato la loro denominazione e non quella bizantina. La loro permanenza nelle aree lungo le vallate del Fullone e del Malosa durò a lungo e fu all'origine degli insediamenti successivi. Non dovette essere facile la loro vita, visto che il termine che li distingueva, tribulisi, in quanto appartenenti ad una tribù, negli anni mutò in trivulusi e tribolati! L'immagine che vi ho offerto, di un Guiscardo che avanza da Scribla verso le nostre terre portando con sé sessanta sclavi, quasi ognuno recasse una spiga di vuda in mano, fa ridere, ma diventa efficace per ricordare il profondo rispetto che quel popolo aveva per i corsi d'acqua, tanto da lasciare proprio nei fiumi e nell'acqua, Vardara, Richetto, Reca Malosa, una traccia indelebile della loro presenza, assieme al nome originario slavo della pianta acquatica presentata in questa pagina del dialetto sammarchese. San Marco Argentano, 8 ottobre 2025 Paolo Chiaselotti |
| |