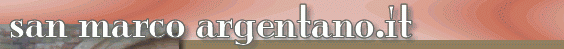 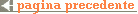 |
 Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti. Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti.
Una storia complicata ... 
A San Marco Argentano le "magare" non sono mai esistite o almeno non conserviamo traccia della loro presenza.
La parola "magara -al plurale "magare"- è tuttavia presente nel nostro
vocabolario sammarchese col significato di donna che ha, o assume in talune circostanze, l'aspetto di una strega.
Esistono o, meglio, esistevano anche delle donne che facevano i sortilegi, le magarie, ma non erano chiamate magare come ad esempio a San Fili e in altri comuni della Calabria. La fattucchiera nostrana era definita semplicemente fimmina ca facia 'li magarie, donna che faceva le magarie, preparando filtri o amuleti destinati a determinare il futuro della persona che le si rivolgeva. Tralascio ogni considerazione o approfondimento in merito a dette pratiche, in quanto lo scopo di questa pagina è solo quello di indagare le origini dei termini magare e magarie nella nostra realtà locale. Non escludo che l'argomento possa essere esteso ad altre realtà, ma anche questa evenienza non rientra tra i propositi che mi pongo, in quanto ritengo che ogni realtà abbia propri percorsi storici e culturali non sempre assimilabili. Inizio subito spiegando il motivo per cui ho introdotto l'argomento con l'immagine di un'asina. Non si tratta di un'asina qualsiasi, ma specificatamente di un esemplare fotografato ai piedi della collina di Scribla, quella da cui circa mille anni fa partì Roberto il Guiscardo con i suoi uomini per raggiungere le nostre terre. Come ho dimostrato su alcune pagine dell'antistoria, sul sito www.lastorialestorie.it, gli uomini al seguito del Guiscardo erano dei fanti di origine macedone, che lo storico Goffredo Malaterra definisce sclavi, termine latino che, assieme a sclaveni, era usato per indicare tribù di origine slava al servizio dei bizantini. Ciò detto, l'animale che noi chiamiamo asino o asina in macedone è chiamato magare (cirillico "магаре"). Bosniaci e croati lo chiamano magarac, i rumeni măgar. Come si vede c'è una evidente somiglianza linguistica con i nostri magara, magare, ma ciò non può essere addotto come prova di una diretta discendenza del nostro termine da uno uguale di origine slava. Infatti entrambi potrebbero derivare da un'altra parola e aver assunto per motivi a me ignoti, significati diversi, o trarre ciascuno origine da due etimi diversi. I casi di parole identiche, anche in una stessa lingua, ma con significati completamente diversi, non sono infrequenti. Analogamente, però, non possiamo escludere che la parola slava possa essere entrata nella nostra lingua ed essere stata interpretata con un significato diverso da quello originale. Qualcosa di simile è avvenuto con il termine dialettale tamarro, rozzo, con cui era chiamato il venditore arabo di datteri (in arabo تمر, tamr). Si vuole che magara abbia, invece, origine greca. Prima di esaminare questa possibilità, va detto che la parola originaria deve trovare un suo uso costante fino all'epoca in cui la parola fu usata. Poiché non siamo in Grecia, né nell'Italia al tempo del dominio bizantino, dovremmo trovare la parola magara in epoche successive e nel nostro caso in anni seguenti al periodo della dominazione bizantina. Ebbene non troviamo alcuna testimonianza di questa parola, non solo in periodo successivo, ma anche nei secoli antecedenti. L'affermazione che essa tragga origine dalla radice greca μαγ- per testimoniare un'origine antica quanto misteriosa è superflua, in quanto le voci che potrebbero condurre all'etimo di magara possiamo comodamente trovarle nella nostra radice italica mag-: mago, magico, magia, ecc. Affermare, invece, che un tale fossile linguistico greco sia stato 'ibernato' per secoli, senza aver mai generato una parola accostabile a magara, non è fantasioso, ma inconsistente sotto ogni profilo. Infatti, nessun vocabolo del genere è documentato nel VI secolo da uno dei maggiori studiosi dell'epoca, Isidoro da Siviglia (nell'edizione curata da Angelo Valastro Canale - UTET). Vediamo, allora, se troviamo magara o una voce che le assomigli tra quelle presenti nel tardo latino. Con questo fine ci affidiamo ad uno dei dizionari più accreditati, il Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, di Du Cange et al., Niort, L. Favre, 1883-1887, nella versione on-line, liberamente consultabile. Non troviamo alcuna voce magara o simile, tranne in un magarizare (http://ducange.enc.sorbonne.fr/MAGARIZARE?clear=1), col significato di subire conseguenze dall'apostasia-conversione cristiano-musulmana, che soltanto chi si diletta nella ricerca di legami occulti tra religione e superstizione può essere tentato di collegare alle nostre magare. Da alcune discussioni sui 'social', riguardanti espressioni, voci e modi di dire dialettali, leggo che il termine magara, troverebbe una sua corrispondenza in megera e masciara. Niente affatto. La prima voce trae origine dal nome di una delle Erinni e si avvicina al concetto che noi abbiamo di magara col riferimento all'aspetto iracondo, ma non a pratiche divinatorie. Il secondo termine, invece, usato nel medioevo nella dizione mascha, equivaleva a strega, altrimenti detta stria. "Magara" resta, allora, una voce a sè, presente in alcune aree specifiche del cosentino, pur con accezioni diverse. Come spiegarne tale particolare presenza? Non escluderei che l'asino abbia fatto la sua buona parte e assieme a lui coloro che lo commercializzavano e lo allevavano. Come sappiamo da tempi a noi recenti il popolo rom, quello che un tempo veniva chiamato in vari modi dagli altri popoli, era specializzato in questa attività. Le fiere erano l'occasione di maggiori contatti, compravendite e scambi. Le donne spesso, con un eloquio misto di parole apprese nel corso di secoli e di frequentazioni diverse, apparivano dotate di capacità soprannaturali di chiaroveggenza. Per conoscere il proprio futuro, per chiedere fatture e sortilegi, affidandosi all'astrologia, alla cabala, alle carte, alla lettura della mano, bisognava rivolgersi esclusivamente alle donne rom. L'asino o l'onagro, che era all'origine di lontane culture, credenze e superstizioni, era nello stesso tempo l'animale maggiormente impiegato in ogni genere di lavoro. Nel campo dell'alimentazione umana il suo prezioso latte suppliva a quello materno. L'asino era l'animale docile e obbediente che le chiromanti chiamavano nella loro lingua magare. Tutto questo finì per accomunare le bestie alle donne che le possedevano, originando una parola magica e misteriosa. Che il termine slavo-macedone o quello bosniaco-croato possano essere entrati nel nostro dizionario dialettale come equivalente di fattucchiera non è improbabile, considerato che i rom di etnia slava, erano presenti attivamente nei nostri comuni, non solo per la vendita di asini e muli, ma per altre attività artigiane (calderai, fabbri, maniscalchi) e artistiche (suonatori ambulanti). Insomma, l'affermazione che la voce possa essere entrata attraverso quella cultura non è campata in aria. Concludendo, se il mite ciuchino, che, a sua insaputa, ebbe tali e tante citazioni e attribuzioni nella storia e nella letteratura, fosse stato o meno la 'vettura linguistica' del passaggio dal suo nome slavo alle nostre magare, rimarrà nelle pagine dell'Antistoria di San Marco Argentano, la città in cui il Guiscardo visse la sua epopea balorda assieme a sessanta sclavi. O zingari?* La nostra indagine dovrebbe, a questo punto, spostarsi su 'Atsingani' e 'Atzinganoi', su un'eventuale presenza i Calabria, su ... Lasciamo perdere. San Marco Argentano, 23 settembre 2025 Paolo Chiaselotti
* Una tradizione costante di allevamento e vendita di asini, muli e cavalli, ha caratterizzato alcuni paesi del meridione
come Cassano e Bisignano. Non saprei dire se in tempi passati anche San Fili o zone limitrofe rientrassero tra questi.
Voglio dire un'assurdità. Considerato che l'etimologia degli ungheresi, ovvero di Ungari e di Magiari, è controversa e di difficile interpretazione e considerando che nei loro nomi c'è qualcosa che ricorda onagri e magare, visto che a metter loro i nomi furono altre popolazioni, non mi dispiacerebbe che gli asini potessero vantare anch'essi una storia epica ... |
| |