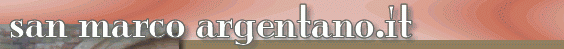 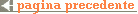 |
 Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti. Sutt'a lingua: Curiosità e approfondimenti.
Un sasso nella scarpa ... 
Avrei potuto sottotitolare questa pagina in centinaia di modi diversi, per richiamare l'attenzione
del lettore sulle implicazioni di una 'parolina' sammarchese indicante una piccola pietra. Ho
scelto la famosa dizione che è all'origine dello scandalo per i motivi che dirò appresso.
Comunque, sono certo che questa parola solleciterà l'interesse di migliaia di persone, non solo sammarchesi,
ma anche oltre le mura di questa piccola cittadina. Un po' come è accaduto per la parola scarpa,
uscita da San Marco nell'XI secolo grazie al Malaterra e a sessanta slavi macedoni.
Come sempre accade sono le piccole cose quelle che, alla fine, reggono il peso maggiore senza mai deperire, ma sono anche quelle che si confondono per la loro enorme quantità da sembrare tutte uguali. Tra queste piccole cose a volte dobbiamo includere anche le persone, che nella moltitudine non rappresentano nulla e spesso lo sono, quando attraversano in massa le acque nere che le separano dagli altri simili. Chi disse che pietra e Pietro erano la stessa cosa e che su di essa si potevano radunare le genti aveva un'idea chiarissima del mondo, ma da un'ottica privilegiata. Ora riduciamo gli spazi siderali che dividono il nostro piccolo e pressocché ignoto paese dal resto dell'universo e parliamo della nostra savurra. Qui è una piccola pietra che serviva ai muratori scalpellini per riempire un piccolo spazio, l'interstizio, tra pietre più grandi, nella costruzione dei cosiddetti muri a secco, ovvero quelli privi di malta, che necessitavano di una perfetta stabilità. Per quanto la pietra grande potesse essere vantaggiosa, importante e 'nobile', la savurra svolgeva il suo importante ruolo di equilibrio dell'insieme e poiché, come tutti sanno, le parole sono pietre, ecco che la savurra entra in gioco anche nella comprensione del linguaggio, ovvero di quella forma di comunicazione tra persone, genti e popoli. Io credo, presuntuosamente, che il padre della lingua italiana, Dante Alighieri, abbia preso a prestito questa voce -il cui suono, in altri ambiti regionali, si era trasformato in zavorra- per indicare la bolgia dei ladri nel settimo canto dell'Inferno. E noi italiani, sulle sue orme, l'abbiamo adottata convinti che si trattasse di un epiteto riferito a questi ultimi in termine di gentaglia. Pensare che Dante abbia potuto confondere il contenitore con il contenuto, ovvero la bolgia con la gentaglia che vi dimorava in eterno, attribuendo ad essi il termine di zavorra umana, è stato un grave errore di interpretazione e, soprattutto un'offesa alla consapevolezza di un 'umanista' del valore dell'Uomo, qualunque fossero le sue colpe, nel caso specifico quelle di sottrarre ad altri i beni materiali. La bolgia o il girone è il contenitore dei condannati all'espiazione e la zavorra è l'equivalente del muro che li contiene, quello che gli altri erigono per difendere le proprie cose. Del resto, se questo pensiero è venuto alla mente ad un imbecille come me, non è logico che prima di me lo abbia formulato Dante?!* Ecco, allora, che quella zavorra a cui noi attribuiamo il significato dispregiativo di un peso di cui vorremmo liberarci, nulla ha in comune con la nostra savurra, anche se entrambi sono figli di una stessa madre, la saburra di Roma. Gli antichi romani saburravano il proprio ventre e quello delle navi quando vi stivavano la saburra, il carico, che una volta gettato sul fondo era merce che appesantiva le imbarcazioni. Poteva essere carico, merce, peso in una parola era zavorra. Un po' come tutto ciò che ci circonda diventa 'cosa' e con le 'cose' indichiamo il bello, il brutto, il buono e il cattivo che in verità sono elementi della vita. Insomma, la nostra savurra restituisce quell'identità e quell'importanza alla pietra comune. E a riprova di quanto dico c'è la testimonianza di due persone, una ormai tra i defunti e l'altra che si occupò della sistemazione dei loro corpi, le quali mi 'consegnarono' queste parole, savurra e una sua derivazione savurria, perché le custodissi assieme alle altre che formano la nostra cultura. Come le savurre nella savurria, anche le due persone, nella massa dei suggeritori, hanno un nome. Una si chiamava Virginia Grosso Perrone, alias Maniglione per acquisizione maritale, l'altra si chiama Stefano Langella, con un trascorso lavorativo di custode cimiteriale. Due persone che possiamo definire comuni, appartenenti a quella massa di cittadini italiani, di cui la grandissima parte ne ignora l'esistenza. Il paragone, anche se materializzato in ambito lapideo, risponde pienamente a quanto voglio intendere: il valore della vita e delle persone. Senza Virginia e Stefano non avrei mai scritto questa pagina, né avrei mai saputo che a San Marco Argentano il maestro mentre metteva in piedi un muro a secco chiedeva al discepolo di porgergli una savurra o un cuticchiu, una pietra più piccola, a seconda dell'esigenza. Come vedete sono persone comuni, compresi l'anonimo maestro e il suo discepolo, ad aver tramandato un pezzo di storia con tutto il suo retroterra culturale. Io ne sono soltanto il trascrittore, l'amanuense. La preziosità delle loro informazioni va ben oltre la semplice derivazione latina, ma affonda addirittura la sua pregnanza immateriale, oltre a quella materiale di immediata lettura, nel Corano, e precisamente nella sura, ovvero in quella che noi definiamo capitolo, ma che in verità si tratta di una ripartizione, di una parte, di una parete, di un muretto in cui la sacra scrittura islamica è suddivisa. Quella sura deriva infatti dall'arabo sawra (سورة) che trae origine proprio dall'etimo sawr (سور) col significato di muro. Potremmo definire la nostra savurra come quella che i romani chiamavano pars pro toto e che noi chiamiamo sineddoche per indicare mediante la pietra un intero muro. Ma la storia delle affinità della nostra savurra non finisce qui, in quanto essa entra a far parte di quel termine suburra che una serie televisa ha reso nota al grande pubblico come quartiere malfamato. La suburra, che dovrebbe derivare da una improponibile sub urbium romana, è in verità il quartiere, considerato malfamato, che sta al di fuori delle mura della città. Al contrario il sobborgo, essendo medievale, stava al di sotto del borgo costruito sull'altura. La suburra è spiegabile, al pari della zavorra, da quel concetto che nei secoli si è materializzato nel significato di peso sociale, la zavorra umana, da lasciare al di là del muro. O delle mura. O dei muri che si vogliono erigere per impedirne il contatto. Pensate che questa estrema correlazione mi sia venuta a mente casualmente ? Neanche per sogno. Come sempre, è l'altro che ci aiuta e nel caso in questione, l'altro di me, che mi ha indotto a riflettere sul suburra risponde al nome di Ivo Zunica. Ritornando all'esclusione, almeno noi, sammarchesi, abbiamo la coscienza a posto. Siamo ospitali. O quasi, visto che i nostri antenati eressero la porta delli Tribulisi a Capo delle Rose, per tener fuori dalle mura la tribù di slavi della Vardara. E per chiudere la questione andiamo a vedere se la nostra savurra ha qualche conferma o corrispondenza fuori provincia. Leggo su uno stralcio di Facebook "AMA LAMEZIA TERME..." che Francesco Domenico Mete ricorda il valore di savurri e chjiancotte** ... San Marco Argentano, 1° settembre 2025 Paolo Chiaselotti * Ovviamente non è logico: il mio paradosso scherzoso attribuisce anche a Dante la mia imbecillità ... ** Le chjiancotte, a quanto mi pare di capire, erano i cocci di cotto più piani, mediante i quali si allineava e si livellava orizzontalmente la direzione delle pietre |
| |